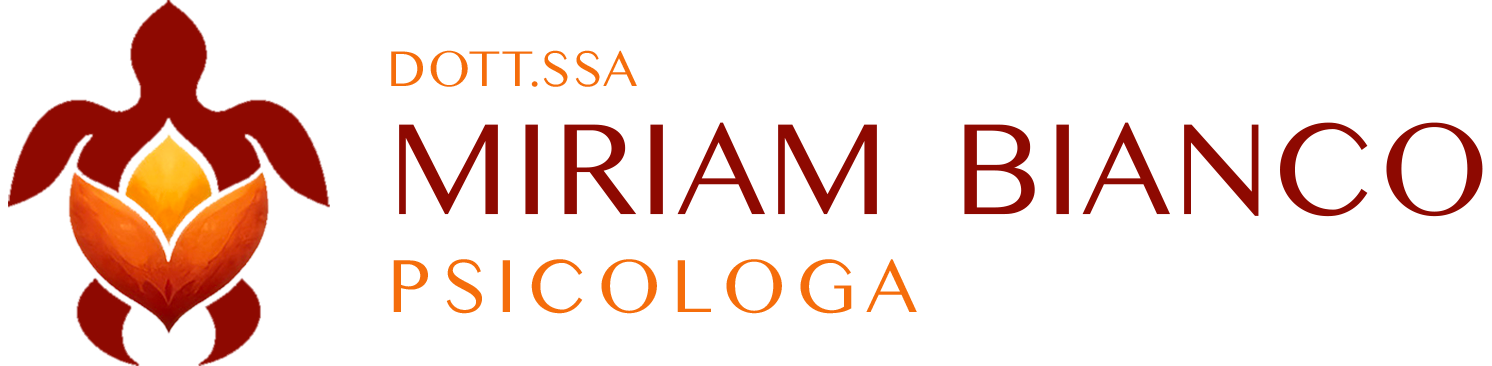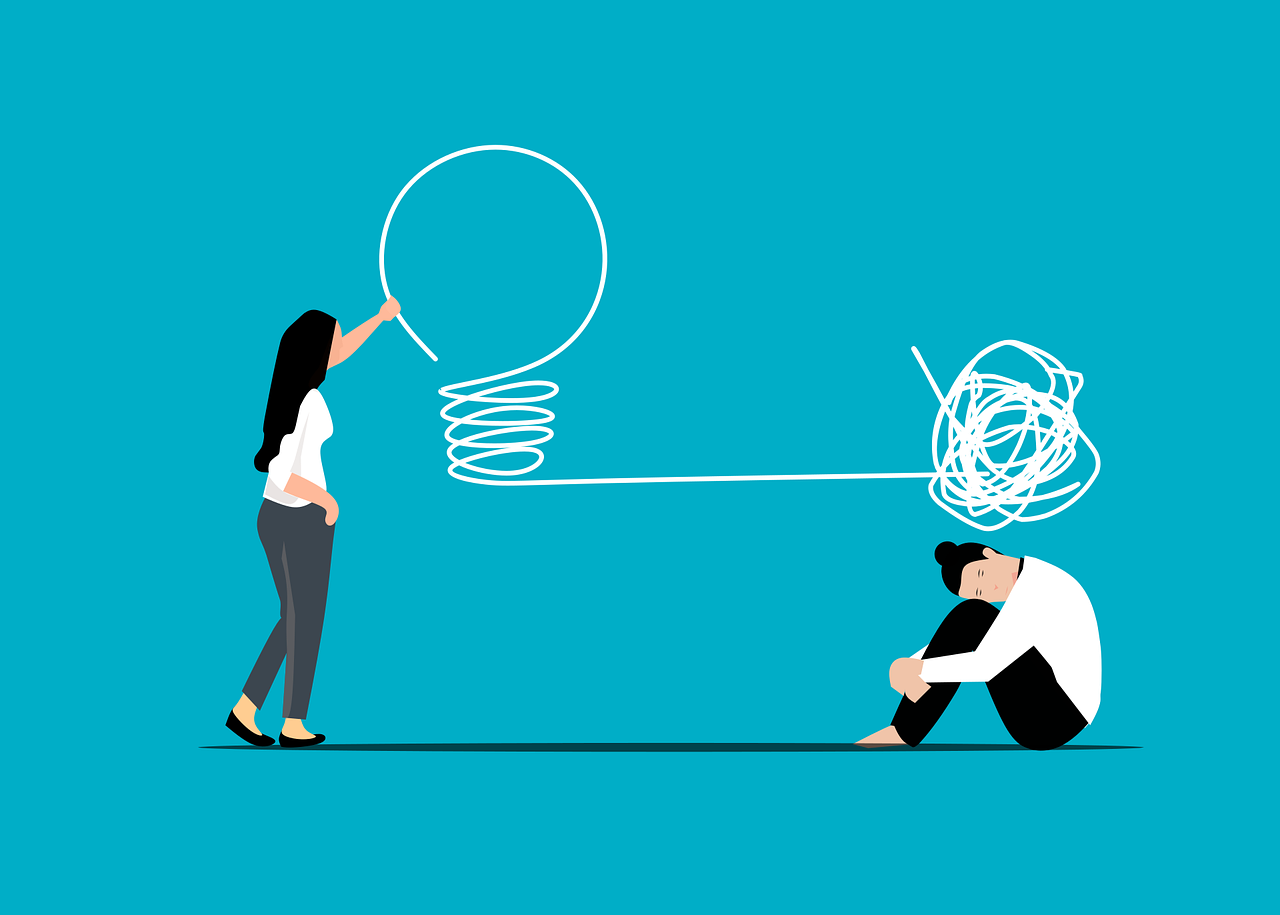Il termine resilienza deriva dal verbo latino resilio che significa rimbalzare. Questo termine deriva dalla fisica e fu introdotto in psicologia per la prima volta da Werner e Smith (Werner & Smith, 1992); con il termine resilienza si intende infatti la capacità di un individuo di resistere agli urti della vita senza spezzarsi o incrinarsi, mantenendo e potenziando inoltre le proprie risorse sul piano personale e sociale. È come la capacità di un malato di assorbire un «urto» come la malattia, senza però «frantumarsi» ma addirittura migliorando (Oliverio Ferraris, 2003).
Werner e Smith condussero un’importante ricerca su dei neonati. Un terzo di questi aveva i prerequisiti per una prognosi di disagio psichico, come ad esempio una nascita difficile o famiglie con problemi di alcolismo o malattie mentali; al contrario rispetto a quanto previsto però, un terzo di questi bambini da adulti riuscì a cambiare in meglio la propria condizione di vita. A questo punto il focus della ricerca si focalizzò sulla resilienza.
In letteratura è presente un dibattito che vede da una parte la resilienza come un tratto di personalità stabile nel tempo e misurabile e, dall’altra parte, la resilienza viene considerata un processo dinamico.
Richardson (2002) prova a dare una risposta diversa a questo dibattito; egli sostiene che alcune qualità resilienti sono presenti fin dalla nascita in ognuno, ma possono essere anche incrementate durante l’arco della vita.
Molti studi si sono focalizzati sull’identificazione delle principali caratteristiche sia di tipo fisico che psicologico che ci consentono di superare i problemi.
Wagnild e Young (1993), in un loro studio, hanno individuato un cluster di tratti di personalità che aiutano in caso di lutto o perdita, e sono ad esempio: una visione equilibrata della vita, costanza e fiducia in se stessi.
Oliverio Ferraris (2003) considera invece due attitudini. La prima non è resiliente ed è definita retroattiva; i soggetti caratterizzati da questa attitudine considerano il mondo circostante come ostile, e attribuiscono la colpa di ogni cosa all’esterno; questo fa si che il soggetto non si attivi per superare gli eventi negativi. La seconda attitudine è detta proattiva ed è tipica delle persone resilienti, infatti questi soggetti, pur essendo consapevoli che certe cose non sono totalmente controllabili, mettono in ogni caso in atto strategie per superare i problemi.
Burns (1996) infine ha individuato quattro macro categorie di attitudini tipiche dei soggetti resilienti. La prima è l’autonomia, che comprende ad esempio una buona autostima, un forte senso di autoefficacia e un locus of control interno; la seconda è la capacita di problem solving di cui fanno parte, ad esempio, un pensiero critico, la capacità di fare progetti e buone capacità immaginative; la terza è l’abilità sociale, che comprende abilità come l’essere flessibili, essere empatici con gli altri e avere buone abilità nell’ ambito della comunicazione. Infine l’ultima macro categoria riguarda i propositi per il futuro; quest’area comprende qualità come: avere obiettivi chiari e ben definiti, ottenere buoni risultati, avere forti aspettative ed essere tenaci (Putton & Fortugno, 2006).
Rutter (1987) delineò alcuni fattori di rischio e alcuni fattori protettivi. I primi studi sulla resilienza focalizzarono l’attenzione sulle conseguenze di un solo fattore di rischio ma negli ultimi anni si è visto che è un insieme di fattori di rischio, e non uno singolo, ad esercitare un effetto dannoso nell’adattamento e nello sviluppo dell’individuo (Robins & Rutter, 1990).
Bisogna inoltre sottolineare che il fattore di rischio descrive una probabilità e non per forza un rischio reale; ad esempio un bambino cresciuto in una famiglia con una situazione socio-economica negativa non necessariamente è stato trascurato anche se una situazione economica negativa viene considerata un fattore di rischio.
I fattori di protezione sono considerati l’esatto opposto dei fattori di rischio; ad esempio una madre premurosa e curante nei confronti del figlio è considerato un fattore di protezione mentre una madre che trascura il figlio un fattore di rischio; non sempre è cosi, in alcuni casi lo stesso fattore, anche se di protezione, se portato all’estremo diventa un fattore di rischio, ad esempio l’autorevolezza dei genitori se è della giusta intensità è un fattore di protezione, ma se portata agli estremi (eccessiva o scarsa) può diventare un fattore di rischio.
Affinché un individuo sviluppi la resilienza, è essenziale prima di tutto che faccia esperienze che lo portino ad aumentare il suo senso di autostima e autoefficacia, e inoltre che abbia come modello una figura di riferimento positiva all’interno della famiglia o anche esterna a essa, ma che abbia quindi una rete di sostegno sociale fin dall’infanzia (Losel, 1994).
Bibliografia
Burns, E. T. (1996). From risk to resilience: A journey with hearth for our children, our future. Dallas: Marco Polo.
Losel, F. (1994). Resilience in childhood and adolescence. Children Worldwide, 211, 8-11.
Oliverio Ferraris, A. (2003). La forza d'animo. Milano: Rizzoli.
Putton, A., & Fortugno, M. (2006). Affrontare la vita. Che cos'è la resilienza e come svilupparla. Roma: Carocci.
Richardson, G. E. (2002). The metatheory of resilience and resiliency. Journal of Clinical Psychology, 58(3), 307-321.
Robins, L., & Rutter, M. (1990). Straight and devious pahtways from childhood to adulthood. Cambridge: Cambridge University Press.
Wagnild, G. M., & Young, H. M. (1993). Development and psychometric evaluation of the resilience scale. Journal of Nursing Measurement, 1(2), 165-178.
Werner; E., & Smith, R. S. (1992). Overcoming the odds: High risk children for birth to adulthood. Ithaca. New York Cornell University Press.